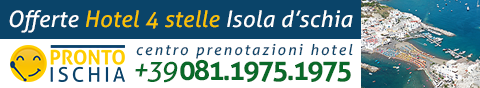Perugia
Perugia
Perugia è un compendio fedele dello spirito umbro. La cinta muraria, per esempio, reca tracce etrusche, romane e rinascimentali; analogamente, l’articolato sistema viario del centro è fatto di vicoli risalenti alla civiltà etrusca mentre corsi e piazze si sono sviluppati durante il XIX secolo. I rimandi storici non finiscono qua, perché anche l’artigianato di prossimità, che a Perugia sopravvive a dispetto dei tempi, è erede diretto delle corporazioni medievali dei mestieri. Corporazioni di cui v’è traccia nei musei allestiti ai primi piani di quel Palazzo dei Priori che insieme a Piazza IV Novembre e alla Cattedrale di San Lorenzo sono tra i maggiori punti di interesse della città. E, sempre a proposito di musei, menzione obbligata per la Galleria Nazionale dell’Umbria, una delle pinacoteche più importanti d’Italia – sicuramente la più importante della regione – anch’essa ubicata all’interno del già citato Palazzo dei Priori. La collezione annovera diverse tele di Pietro Vannucci, detto “Il Perugino“, oltre a opere di Beato Angelico, Piero della Francesca e Bernardino di Betto Betti, in arte “Pinturicchio“. Insomma, a Perugia tutto è storia, e la vicenda della Rocca Paolina n’è ulteriore conferma. Infatti questa costruzione, simbolo del dominio pontificio sulla città, venne distrutta dopo la fine del processo unitario per far posto, appunto, a Piazza Italia, suggello del vittorioso Risorgimento. La storicità dei luoghi, però, non va a discapito della modernità. Al contrario, Perugia è una città all’avanguardia per i servizi offerti. In particolare, la mobilità: dalle scale mobili per arrivare in centro, al Minimetrò, linea ferroviaria a doppio binario che collega tutte le principali porte d’ingresso cittadine. Menzione obbligata, infine, per due eventi di caratura internazionale: Umbria Jazz (UJ) che tradizionalmente si svolge a luglio ed Eurochocolate, manifestazione gastronomica interamente dedicata al cioccolato che invece si svolge nel mese di ottobre. Da vedere!