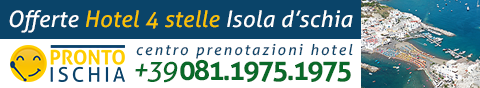Trekking a Pantelleria
Trekking a Pantelleria
La più grande delle isole siciliane, nonché la quarta in Italia per estensione territoriale (preceduta appunto da Sicilia, Sardegna ed Elba) è un paradiso per gli amanti del trekking. L’isola infatti vanta 21 itinerari escursionistici, tutti mappati e manutenuti dall’ente parco di Pantelleria per offrire la migliore esperienza possibile agli escursionisti che decidono di visitarla. Altro aspetto interessante è che dei suddetti sentieri nessuno presenta grosse difficoltà. Ovviamente occorrono un minimo di dimestichezza e preparazione fisica e, va da sé, il rispetto di tutti gli accorgimenti in uso – dall’abbigliamento, alla tutela dell’ambiente – di chi va per sentieri. Tuttavia, al netto di queste cautele, la rete sentieristica di Pantelleria è adatta a tutti. Da fare!