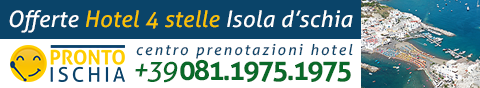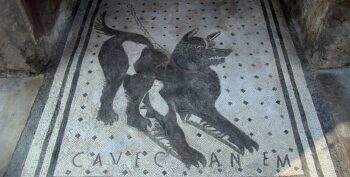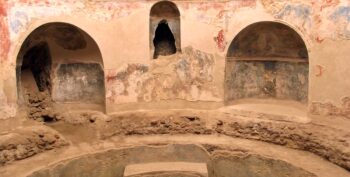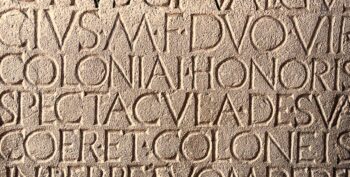Le spiagge di Spalato
Le spiagge di Spalato
Oltre alle già menzionate Kašjuni e Bene (vd. punto 5), meritano attenzione anche le spiagge di Kaštelet e Bačvice. Come le prime due, anche Kaštelet è raggiungibile dal monte Marjan, mentre Bačvice, ampia e a pochi passi dal centro, è senza dubbio la spiaggia più famosa e frequentata di Spalato. Non a caso viene spesso paragonata alla celebre Copacabana di Rio de Janeiro, e non solo per la sua importanza storica, ma anche per il ruolo centrale che lo sport riveste qui. A Bačvice si praticano beach soccer, beach volley e, soprattutto, picigin, un gioco tradizionale che si svolge sulla riva – dove il fondale è sabbioso e poco profondo – con una pallina di gomma, scambiata tra i giocatori con colpi di mano. Altre spiagge degne di nota sono Ovcice, Firule e Znjan, che offrono un ambiente più rilassato e tranquillo, senza rinunciare ai comfort tipici di una località balneare. In breve, pur non essendo immediatamente riconosciuta come meta balneare, Spalato vanta una grande varietà di spiagge, sia di sabbia sia di ciottoli, e soprattutto un mare cristallino. Tutto da scoprire!