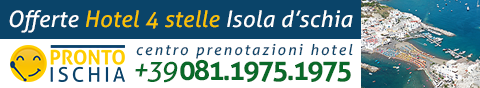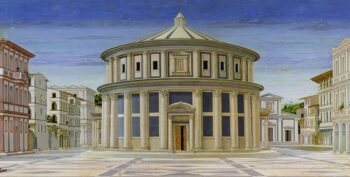Già antica cattedrale di Perugia, l’Abbazia di San Pietro, all’estremità sud della città, è l’ultima tappa del nostro tour alla scoperta del capoluogo umbro. Come ribadito in altre circostanze, la collocazione di un monumento, un punto di interesse, un quartiere, all’interno di una guida è sempre operazione soggettiva. Per dire, noi l’abbiamo messa all’ultimo posto ma sempre più persone, invece, scelgono di visitare questa chiesa per prima, o comunque la mettono in cima alle cose da vedere. Due le ragioni: l’imponente campanile, visibile quasi da ogni lato della città; e la ricchezza decorativa degli interni. Marmi, stucchi, soffitto cassettonato e una gran quantità di tele e affreschi, tra cui opere del Perugino e del Vasari, ornano l’intero edificio che, per spunti artisitici, è secondo soltanto alla Galleria Nazionale dell’Umbria (vd. punto 2). Da una decina d’anni a questa parte, però, il quadro che più incuriosisce è il Trionfo dell’Ordine dei Benedettini realizzato tra il 1592 e il 1594 dall’artista italiano di origini greche, Antonio Vassillachi, detto l’Aliense. Motivo di tanta attenzione è il fatto che da vicino, questa tela, grande 90 metri quadri, rappresenta fedelmente l’Ordine benedettino. Allontanandosi, però, specie dalla prospettiva dell’altare maggiore, lo scenario cambia radicalmente e l’insieme delle figure rappresentate assume addirittura le sembianze di un volto demoniaco. La circostanza ha dato il là a disparate discussioni su quali fossero state le reali intenzioni dell’artista. Quel che è certo, è che a distanza di quasi cinque secoli, Vassillachi è riuscito nell’intento di far parlare di sé, e ovviamente della chiesa dove ha riversato molto del suo ingegno creativo (suoi molti quadri che campeggiano lungo le navate laterali). Da vedere!